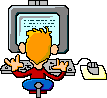Quel
giorno al Pastificio:
Check-point "Pasta"
(Tratto da AREA) - Anno1993. È l’alba del 2
luglio: scatta l’operazione Canguro 11. Si tratta di un rastrellamento,
l’ennesimo, condotto per ripulire di armi e di ribelli il quartiere Uahara Ade,
ovvero la zona attorno al Check-point “Pasta”, che prende il nome dal rudere di
un complesso industriale - un pastificio, appunto - costruito con i soldi della
cooperazione italiana. In questo luogo confluiscono il corso XXI Ottobre e la
Strada Imperiale che porta verso Balad. È in questa zona che ormai da tempo i
militari dell’Onu sono bersagliati da colpi di arma da fuoco di cecchini
isolati.
Dal Villaggio Azzurro del Porto Vecchio si muovono gli uomini del raggruppamento
“Alfa”: parte di loro ha il compito di isolare il lato destro della zona delle
operazioni, mentre gli incursori del IX Col Moschin, appoggiati dai Carabinieri
del Tuscanica e dai parà della V compagnia del 183° Nembo, porteranno a termine
il rastrellamento. Il fianco sinistro, sul lato del pastificio, viene presidiato
dai reparti del raggruppamento “Bravo” provenienti da Balad; in riserva
rimangono, tra l’altro, otto carri pesanti M-60 della brigata Ariete e alcune
blindo Centauro della cavalleria.
Complessivamente sono impegnati circa 500 uomini su Vcc-1 (trasporto truppe
corazzato) e blindati Fiat 6614, appoggiati da un centinaio di poliziotti
locali. Il ruolo C3 (comando-comunicazione-controllo) è affidato ad ufficiali a
bordo degli elicotteri Ab 205, che solcano il cielo di Mogadiscio con i Mangusta
A-129 d’assalto, pronti a segnalare eventuali pericoli e a coordinare il fuoco
di reazione. Si tratta di un’operazione di routine - anche se in grande stile -
il cui obiettivo è quello di rastrellare un quadrilatero di 400 metri per 700,
compreso tra “Pasta” e “Ferro”, l’altro caposaldo italiano in un quartiere con
un’alta densità di uomini della tribù Ha ber ghidir (i temuti guerriglieri del
generale Aidid).
Nelle intenzioni del comando italiano l’imponente schieramento messo in campo
dal generale Bruno Loi punta sull’effetto dissuasivo, considerata l’altissima
tensione che non coinvolge più solo le fazioni locali in lotta tra di loro ma,
da alcune settimane, anche le forze di peacekeeping internazionali. Intorno alle
06:00 una prima colonna si mette in movimento, snodandosi per le vie semideserte
di Mogadiscio, superando il Check point “Pasta” e attestandosi all’interno della
zone delle operazioni: sono scoperti parecchi depositi di armi, e alcuni somali
sono fermati per essere interrogati. Arriva l’ordine di rientrare: anche Canguro
11 va in archivio.
I blindati invertono la marcia e si preparano ad uscire dal quartiere. “Alfa” si
dirige verso “Ferro”, per poi convergere verso il Porto Vecchio; i militari del
gruppo “Bravo” muovono verso “Pasta” per tornare a Balad: la testa di questa
colonna è già giunta a destinazione quando iniziano i problemi. I primi
disordini hanno luogo attorno alle 07:30 nella zona del gruppo “Alfa”: sulle
barricate, sassi e alcune schegge di granata fanno i primi feriti.
L’aria è resa irrespirabile dal fumo acre dei copertoni in fiamme. Ma si tratta
solo di un diversivo. Dietro alla folla di donne e bambini spuntano Ak-47 e Rpg.
I cecchini cominciano a bersagliare sistematicamente gli italiani. Il fuoco è
più intenso intorno agli uomini del gruppo “Bravo” impacciati anche dal
sopraggiungere di alcuni mezzi del genio che intasano le strade: il sottotenente
dei Lancieri di Montebello, Andrea Millevoi si sporge dalla torretta del suo
Centauro per seguire l’evolversi della situazione; una pallottola lo colpisce
alla testa, uccidendolo sul colpo.
Viene fatta confluire la riserva corazzata, che giunge dal Corso 21 Ottobre; i
carristi non sono però autorizzati a far uso del proprio armamento pesante. Tre
Vcc-1 procedono a poca distanza uno d’altro, quando sono investiti da un feroce
fuoco di armi automatiche. Il primo cingolato si piazza al centro dell’incrocio
e risponde con le armi di bordo; la browning M2 da 12,7 mm e la Mg-42/59 da 7,62
mm investono con il loro fuoco le postazioni somale per coprire l’avanzata degli
altri. Il secondo blindato lo segue, mentre il terzo ha fatto appiedare la
propria squadra fucilieri, per mettere gli uomini in una migliore condizione di
tiro.
I miliziani somali attaccano con lanciarazzi Rpg-7 il secondo Vcc, sul quale si
trova, fra gli altri, Pasquale Baccaro, parà del 187°, che viene colpito a morte
dal dardo infuocato mentre sta azionando la sua arma. Dentro il mezzo è
l’inferno: il sergente maggiore Giampiero Monti ha l’addome squarciato, il
paracadutista Massimiliano Zaniolo la mano devastata. Gli uomini del resto della
colonna si schierano a raggiera per difendere i feriti e dar tempo ai soccorsi
di arrivare. Il sottotenente Gianfranco Paglia coordina l’azione, mentre il Vcc
più avanzato, allo scoperto, copre i soldati a terra al centro dell’incrocio
stradale. Si tratta di un vero e proprio corpo a corpo; il nemico non è a più di
20-30 metri, la reazione degli italiani è comunque decisa. Passano i minuti, le
ambulanze e i soccorsi sono bloccati dal fitto fuoco avversario e dalle
barricate. Il mezzo colpito dopo alcuni tentativi viene rimesso in moto, i
feriti vengono caricati di nuovo a bordo, e l’unità lascia il luogo dell’agguato
mentre l’intero quartiere è in rivolta. Si combatte ovunque, lungo la Via
Imperiale, si spara dalle vie traverse, ed in particolare intorno al pastificio.
Un altro razzo colpisce la cupola di un M-60, mentre un altro carro risponde
sparando in rapida successione otto colpi da 105 mm contro la zona da cui è
partita la micidiale salva; il bersaglio è un gruppo di container e di
catapecchie che fanno da riparo ai miliziani. Il capocarro apre il fuoco
violando formalmente le “regole d’ingaggio”, ma nel cuore della battaglia
qualcuno decide che si può rischiare una punizione se c’è in ballo l’incolumità
dei propri camerati. La reazione somala diminuisce d’intensità; la XV compagnia
del Nembo inizia a defluire verso Balad, mentre i mezzi speciali raggiungono il
Porto Vecchio lungo la via Nazionale.
La tregua è di breve durata, e il combattimento riprende rabbioso a colpi d’arma
da fuoco intorno al pastificio. Il comando italiano, dopo essersi ripreso dallo
sgomento dell’imboscata, ordina un contrattacco che viene condotto dagli
“specialisti” del Col Moschin e del Tuscanica. La reazione somala è
inaspettatamente violenta. Si svilupperà un durissimo scontro casa per casa,
durante l’assalto viene colpito a morte il sergente maggiore degli incursori
Stefano Paulicchi. Alla fine dell’azione “Pasta” rimane in mano ai somali, anche
perché il comando italiano preferisce non usare le armi pesanti per non causare
una strage tra i civili inermi. Gli italiani lasciano sul campo, oltre ai morti,
22 feriti, alcuni dei quali molto gravi; tra questi il sottotenente Paglia, che
per l’eroismo dimostrato sul campo sarà insignito della più alta onorificenza.
Mentre le salme dei caduti rientrano in Italia, si alza il tono della polemica
con le Nazioni unite. Il governo italiano infatti non condivide la strategia del
comando unificato Unosom (ispirato dagli Usa), che favorisce l’approccio
militare per cercare di risolvere il problema Somalia; tale approccio porterà al
naufragio della missione Restore hope e - dopo le crude immagini dei ranger
americani linciati dalla folla somala - ad un lungo disimpegno statunitense
durato quasi dieci anni.